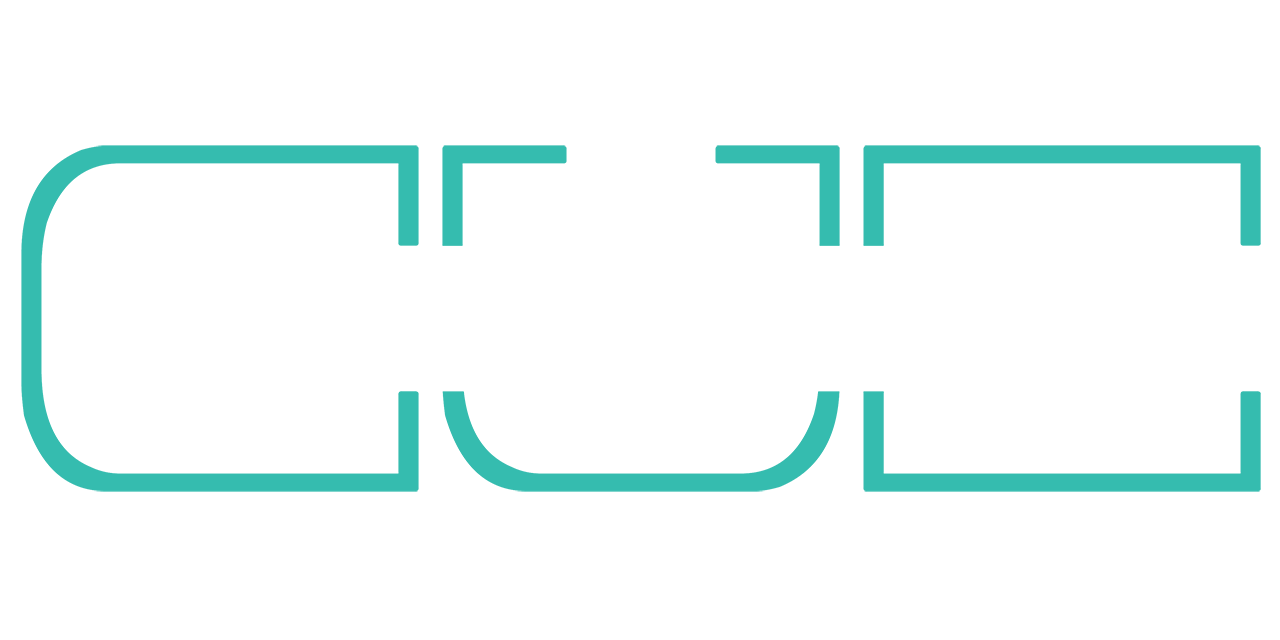Stelle Marine, questa specie è molto più simile a noi di quanto si possa pensare | Discendiamo da un antenato di 500 milioni di anni fa

Illustrazione di una stella marina (Pixabay Foto) - www.marinecue.it
Queste specie sono straordinarie, e sembrano così lontane e diverse da noi. Eppure, siamo molto imparentate con loro.
I deuterostomi sono un gruppo di animali piuttosto particolare, accomunati da un dettaglio che a prima vista può sembrare strano: durante lo sviluppo embrionale, la prima apertura che si forma diventa… l’ano. E la bocca arriva dopo. Curioso, no? È proprio da questa caratteristica che deriva il loro nome (“bocca secondaria”).
In questo gruppo ci finiamo dentro anche noi esseri umani, insieme a creature molto diverse da noi come le stelle marine e i ricci di mare. Sembra assurdo, ma a livello di sviluppo embrionale abbiamo qualcosa in comune.
Le stelle e i ricci, che fanno parte degli echinodermi, vivono in fondo al mare e sono famosi per le loro forme simmetriche (a raggi) e per un esoscheletro calcareo duro e appuntito.
Gli echinodermi hanno anche un sistema acquifero interno super particolare, una specie di impianto idraulico naturale che usano per muoversi, respirare e nutrirsi. Hanno cinque “braccia” o segmenti disposti in modo radiale, il che li rende davvero diversi da noi a prima vista… ma sotto sotto, nella loro “architettura interna”, c’è un legame profondo.
Più vicini di quanto immaginato
Scommetto che non ci hai mai pensato davvero, ma noi esseri umani condividiamo una strana parentela con animali che sembrano venire da un altro pianeta… tipo le stelle marine. Già, proprio quelle con le braccia cicciotte che si muovono lente sul fondale. E non è una parentela solo a livello genetico, ma anche biochimico: pare che condividiamo con loro un ormone che ci dice quando smettere di mangiare. Pazzesco, vero?
Questa molecola si chiama bombesina, ed è quella che, nel nostro cervello e nel nostro intestino, regola la fame. Quando mangiamo, lei si attiva e ci fa sentire sazi. Il punto è che questa funzione, secondo uno studio pubblicato sulla PNAS e realizzato dalla Queen Mary University di Londra, non è roba recente. Anzi, esiste da oltre 500 milioni di anni, quindi molto prima che comparissero i vertebrati. Il che significa che questa “spia della sazietà” era già attiva in un antenato comune a noi e agli echinodermi, tipo stelle e ricci di mare.

Un appetito…millenario
Tutto parte dalla bombesina, che venne isolata nel 1971 dal farmacologo italiano Vittorio Erspamer (già il nome sembra quello di un personaggio da romanzo). La scoprì nella pelle di una rana, la Bombina bombina, e da lì nacque tutta la ricerca su come questo ormone agisce sul senso di fame.
Quando veniva iniettata nei mammiferi, riduceva l’appetito, faceva passare più tempo tra un pasto e l’altro… insomma, era chiaro che funzionava come un “segnale di stop” per il cibo. E oggi, con farmaci come l’Ozempic sulla cresta dell’onda, ci sono studi in corso per creare molecole simili alla bombesina contro l’obesità.